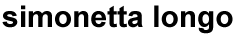Simonetta Longo, Rielaborazione della memoria montaliana in Mario Benedetti, “Il Segnale”, anno XXXVI n. 107, giu. 2017. ISSN: 0393-9464. Articolo critico sulla silloge Pitture nere su carta (2008) di M. Benedetti.
Leggi / Scarica l'articolo critico - Account Academia:http://independent.academia.edu/SimonettaLongo


Simonetta Longo, recensione della silloge Geometrie scalene (2016) di Laura Cantelmo, “Il Segnale”, anno XXXVI, n. 107, giu. 2017. ISSN: 0393-9464.
LAURA CANTELMO
Geometrie scalene
Marco Saya Edizioni, Milano 2016
Il falco nella sera apre
la silloge Geometrie scalene di Laura
Cantelmo (saggio introduttivo di Adam Vaccaro) e indica immediatamente la
prospettiva di lettura nel sogno,
sebbene la dimensione dubitativa del forse
allerti il lettore. Il falco trasvola, sorprende a «fare conti usurai/ con dita acuminate», travolge «i nidi ove nascondono/ prede»: «forse fu solo […] un sogno di falco», la descrizione è di un incubo che escluda luce
e speranza. In Alexandros Pascoli avvertiva che «il sogno è l’infinita ombra del Vero», ma pure che sarebbe stato
meglio «non guardare oltre, sognare».
Così è la storia, la passata e quella in atto, che si adombra, si annida nel
sogno prospettato da Cantelmo, da leggere con occhi diversi (cecità è
disumanità). E se negli occhi disuguali di Alessandro, uno nero e uno azzurro,
la speranza si fa vana nel primo mentre il desiderio cresce nell’altro, anche
qui, in Barca sommersa: «Un occhio rimira imperlate città/ […] forse soltanto sognate./ Un occhio avvilito
si posa/ sul greve respiro del mondo».
Circolarmente, la raccolta si chiude proprio sul sogno, questa volta positivamente connotato: in Cibo d’amore l’invito è a bere «il latte della concordia». Chi vive di
poesia, e non si tratta di un io, ma
di un noi lirico per quasi l’intera
raccolta, per Cantelmo sa che «l’amore
cieco che trasfigura/ il mondo nasce dal sogno».
Ma cosa
c’è tra sogno-incubo e sogno? La storia generale e le storie particolari (in
Occidente e Oriente, da Capaci alle
terribili notti in Siria) con il loro incedere non lineare. Se ci sono delle
geometrie, si tratta di geometrie scalene. Il percorso nel tempo e nello spazio
è irregolare, scaleno appunto, secondo l’etimologia dal gr. ???????? ‘disuguale, zoppicante’. È un
viaggio sghembo come la vita (si legga Geometria
scalena), da VICINO, la Milano della prima sezione Metropolita con l’opposizione
natura-autenticità/città-artificiosità, a LONTANO, i Mari altrove della seconda, tra
le Orbite accese dove mito, leggende
e storia s’intrecciano, e le Orbite
occluse delle stragi, delle guerre, fino alle Migrazioni, per tornare, scalenamente, al ripiegamento del
VICINISSIMO, nell’ultima sezione Anse
d’amore in cui la memoria si fa più personale e dal noi fa capolino l’io: «Conoscemmo la misura del dolore./ […] Credevamo di conoscere il tondo/ della
terra, ne misurammo il raggio/ ma era piatta, circondata da muri,/ matasse di
spine […]. Ti guardavo muta. Da tempo
la parola/ taceva, il pensiero – solo – volava». Dove lo spazio è murato, dove non solo i
reclusi del carcere di Opera (Il violino
incatenato) o San Vittore, i
migranti, ma tutti noi, ormai arrogantemente imbelli, siamo «rinchiusi
fuori» sembra dire Cantelmo, neppure la luziana parola della poesia può
volare alta.
Sotto
l’aspetto formale l’andamento scaleno è reso dalla forte presenza di rime
interne (tra le più notevoli storia/memoria)
e enjambements oltre che, in ambito
retorico, di ossimori (notturni girasoli,
incanto feroce ecc.) e antitesi a
delinearne il carattere spesso oppositivo, in particolare tra
realtà/sogno. C’è un ‘luogo’ che
attraversa l’intera silloge e può rendere questa dimensione scalena con le sue antinomie: il tòpos del locus amoenus e insieme del suo opposto, il locus horridus (questione da approfondire per abbondanza di rimandi
a entrambi i tòpoi tra alberi, acque
e paradisi perduti), strettamente intrecciati (come già in Ovidio e
Shakespeare) a partire dal bosco in
apertura, la metropolitana milanese come Bosco
sotterraneo, chiuso e privato di possibili «corrispondenze» per il poeta, per finire (ancora circolarmente) con
quel bosco, dichiaratamente shakespeariano, aperto e disposto dalla
notte alla nascita della poesia, forse barbara,
contaminata, dissonante armonia (Voci a
Lepanto). Di fronte «al tempo
malsano/ che ci tocca» (quasi il reo
tempo di Foscolo, già evocato in Penelope),
non troppo diverso da un passato mitizzato pur pregno di dolore, tra oscurità
abitate da mostri come le Arpie e il Leviatano e uomini-lupi invisibili o predoni
o eroi compulsivi o bestie feroci contro altri uomini-schiavi, potrebbe
stagliarsi, domani, un’attesa, una promessa, un altro/ futuro.
Simonetta Longo


Simonetta Longo, Hikikomori. Umano non più umano, “Il Segnale”, anno XXXVI, n.
107, giu. 2017. ISSN: 0393-9464. Racconto.


Simonetta Longo, recensione della silloge Il mondo vivibile (2016) di Claudia Azzola, “Il Segnale”, anno XXXVI, n. 106, febb. 2017. ISSN: 0393-9464.
CLAUDIA AZZOLA
Il mondo vivibile
(La Vita Felice, Milano 2016)
«Il mondo è desiderabile, inimitabile, / mirabile/ vivibile/ secondo chi c’è nel
mondo/ a viverlo […]» con questi versi si apre la silloge di Claudia
Azzola Il mondo vivibile. Vivibile,
per definizione, è un mondo che può essere vissuto, sostenibile, in cui è possibile vivere. Ma l’uomo, per Azzola,
è un predatore se sfrutta «fino all’osso»
la natura, se si avventa, homo
homini lupus, sull’altro uomo. Così i versi richiamano l’uomo
postmoderno e tecnologico alla responsabilità di un futuro possibile unicamente
attraverso l’arte e la natura. Se all’uomo, come sostiene Hans Jonas
(autore de Il principio
responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica), si impone il
nuovo imperativo categorico «Agisci in modo che le conseguenze della tua azione
siano compatibili con la sopravvivenza della vita umana sulla terra»,
questa «sopravvivenza» non può che fondarsi, per Azzola, sul binomio
natura-arte. Nella postfazione l'autrice fa esplicitamente riferimento
a Hölderlin: «L’arte è la via della natura alla civiltà e della
civiltà alla natura». In un mondo in cui «Molti
hanno vissuto e non hanno cantato», o amato, nessuno è scampato al «guerreggiare»; in questo mondo, al di là
e contro ogni mancanza di gusto e talento, resta un invito: «sciogliamo versi dopo il dolore». E i
versi, nei 65 testi, vanno a costituire un «poema continuo», fluido, che rende
conto anche del proprio passato (con riprese dalle raccolte precedenti). Che
passa fluidamente di lingua in lingua (italiana e inglese soprattutto, poi
francese, latina, greca, fino ai lessemi in volgare dolzòre-amaròre), di tempo in tempo (e ciclicamente), dai fantasmi
della preistoria al presente con il suo «sprofondo»,
con le «cose che decadono»,
scioglimenti di ghiacci, disboscamenti, inquinamenti e lavoro sottratto,
rivoluzioni industriali e virtuali, ossa rotte di donne, primavere arabe, caos,
nel tentativo di rialzarsi «dall’inesorabile
storia». Scorre ininterrotto di luogo in luogo, di personaggio in
personaggio (Cassandra, Afrodite, Core, Diòtima, e Dioniso, Socrate, Cristo,
Guglielmo il Conquistatore, il Bardo, Amleto, Re Sole ecc.), giustapponendo
tuttavia realtà e in-canto fantastico, carmen-canto
e poema e charm-incantamento
magico. La poesia è il “giardino” segreto della favola da narrare in cui il
poeta è nell’esiliato incantesimo della lingua, il mondo reale è fuori: «non c’è giardino/ senza nascosto suono
d’acqua/ […] Non c’è
giardino senza il verbo dell’esilio». Lo sguardo del poeta procede nello spaesamento,
eccentricamente, obliquamente, avendo appreso che la poesia «non è quietismo», ma «[…] donne e uomini/ in cerchio alle fontaines
de beauté». Poesia per Azzola è canto (numerosi
i riferimenti musicali) naturale («a natural speech flow») e sensoriale, la
cui scaturigine è nel «corpo parlante» dal
quale sgorga una «poesia incarnata».
In questo in-canto è introdotto il lettore che, come nel Ramo d’oro di Frazer, resta sospeso
in un’atmosfera tra reale e irreale, razionale e irrazionale. È insieme storia,
favola e leggenda, con il richiamo a un medioevo, sì barbaro, ma più spesso
rievocato per il fervore culturale, dall’amor cortese alle università, e nei
suoi simboli: oggetti (caprifoglio, velo, anello, armature ecc.); un ricco bestiario
(uccelli di varie specie, cicale, grilli, formiche, pipistrelli ecc.); quêste; alchimia; insistenza sui
quattro elementi naturali, con larga predominanza dell’orbis aquarum. E al trobar
clus (e a un certo dettato «ermetico») rimanda lo stile dell’autrice,
che apertamente dichiara di stare tra «due
oscurità/ della lingua e dello stretto sentire». È uno stile prezioso,
rivelatore anche di una consonanza con la lirica elisabettiana di fine
Cinquecento, che ricorre (nell'avvicendamento di versi sciolti e canonici – con
frequenti endecasillabi) a numerosi strumenti retorici, di cui si
segnalano il procedere analogico di concetti e immagini, l’abbondanza di figure
fonetiche (in particolare la rimalmezzo, l’allitterazione, ad es. «aSSenza SeMe che SMorza e S-Muore»),
enjambements, parallelismi e riprese semantiche che, concatenando i testi,
liberano una poesia scorrente. La poesia
di Azzola è una poesia liquida della
memoria, ossimoro di una «fiaba vera» narrata fuori dal tempo nel corso del
tempo, in cui il lieto fine – scongiurata la «débacle esistenziale» con la fine delle parole, se una «salvazione» è possibile – ancora una
volta è affidato a una veglia d’arte. «It is high time», è il momento della poesia. E della natura.
Simonetta Longo


Simonetta Longo, L'identità straniata poeta-popolo in Roberto Bertoldo, “Il Segnale”, anno XXXV, n. 105, ott. 2016. ISSN: 0393-9464. Articolo critico sulla silloge Il popolo che sono (2015) di R. Bertoldo.
L'IDENTITÀ STRANIATA POETA-POPOLO IN ROBERTO BERTOLDO(Roberto Bertoldo, Il popolo che sono, Mimesis, Milano 2015)
La silloge Il
popolo che sono si apre con un «Io» poetante che dichiara fin da subito,
con un efficace chiasmo, la sua funzione, «Io
parlo poesie come i fabbri schegge/ e festuche i falegnami»: la funzione di
“fabbro di parole” pone già in premessa, attraverso la similitudine, il poeta
in posizione analoga a quella del fabbro tout court e del falegname. Il poeta
ha per strumenti pagine «di idee» e «altri materiali» per forgiare il verso e
conosce il male e la morte. Ma c’è di più, il poeta non vuole avere voce per sé
stesso, poiché ha dentro di sé, nel suo corpo, il popolo, poiché è il popolo. «Ma io ho, dentro di me,/ il popolo che sono», con il verso in
explicit della prima poesia, programmatico, a intitolare l’intera opera. Sul
piano sintattico, la proposizione «Il popolo che sono» si presta ad un’analisi
per cui il “popolo” (termine occorrente ben ventidue volte solo nella forma
singolare a esplicitarne la centralità) è “oggetto” che diventa “soggetto”
nell’identificazione con l’io poetante. E l’immedesimazione poeta-popolo è
riaffermata nel passaggio dall’“io” al “noi” della seconda poesia, I distici della notte, in cui
l’antagonista è la poesia della «parola venduta», la poesia decorativa dei «poeti
puliti», acclamati «nababbi di apollo/
gentilizi dell’anima», contro cui, per sineddoche, «le nostre mani che hanno terra», e quindi il «noi» poeta-popolo, «gridano con gli ultimi tendini/ fino a
troncare il colore pingue/ dei vostri aggettivi». Emerge dunque, di fronte
e soprattutto contro l’io-noi di poeta-popolo, un antagonista, un nemico
irriducibile, un «voi» in posizione dialettica, senza possibile sintesi. Questo
«voi» antitetico, di testo in testo, nelle settantasei liriche che compongono
il libro, in una successione senza soluzione di continuità (in assenza di
sezioni distinte, frequenti sono i rimandi tra un componimento e il successivo),
è la poesia del disimpegno postmoderna, la religione di «quel dio a cui consegniamo,/ come fiacchi servi, la direzione del
nostro tramonto» (Filari di querce),
il capitalismo e il potere politico che opprimono gli uomini, il nichilismo
distruttivo contro cui Bertoldo oppone il Nullismo e una letteratura e un’arte
che, attraverso l’impegno civile, possano filosoficamente giustificarsi affrancando
l’uomo. (Cfr. R. Bertoldo, Nullismo e
letteratura, 1998 e Principi di
fenomenognomica con applicazione alla letteratura, 2003). L’andamento
dialettico è evidente nell’opposizione semantica: io(poeta)-noi(popolo)/voi, poveri/ricchi,
plebei/patrizi, servi/padroni, deboli/forti, fino all’antitesi poeta/padre,
poeta/paese; e nell’opposizione concreta che necessita, secondo la lezione di
Camus, la «rivolta», il «mi rivolto, dunque
siamo».
Il popolo cui dà voce Bertoldo non è la romantica
entità che comprende tutti gli individui di un Paese, è, come già per i greci
Erodoto e Tucidide, la parte più numerosa di esso, quella esclusa dal potere, sfruttata,
arresa e offesa («i più poveri», «i più vecchi», «le puttane», gli stessi umili
cantati da Saba in Città vecchia). Un’umanità
dolorante, resa cieca e servile dai potenti («Spesso i popoli sono di sabbia efferata» in I popoli) come dalla religione, bersagli contro cui il poeta-popolo
usa la «sferza» delle parole in uno stile espressionistico che richiama il «pugno»
e più ancora il «grido». L’andamento dei versi è spezzato e spietato, dal
pathos esasperato, a dire la rabbia, La
violenza («Dite violenza di ogni
parola vera/ perché non sapete che la morte è un agguato»), il male, il marciume,
l’inferno in terra e la morte, attraverso un lessico che rimanda frequentemente
da un lato alla guerra, «Io popolo che
graffio la sintassi/ sono la rivolta che ama/ la lingua e la sciabola» (Il male), dall’altro al cristianesimo, «sono il tuo prete ateo…» arriva a dire
il poeta con uno spiazzante ossimoro in Sopra
una lapide. Camus, cui Bertoldo fa più volte riferimento nei suoi testi di
filosofia e teoria della letteratura, ne La
rivolta libertaria affermava: «Il mondo in cui vivo mi ripugna, ma mi
sento solidale con le persone che vi soffrono. […] un'altra dovrebbe essere
l'ambizione di tutti gli scrittori: testimoniare ed elevare un grido, ogni
volta che sia possibile, nei limiti del nostro talento, a favore di coloro che,
come noi, sono asserviti». Un simile ambizione è presente nella poesia indignata
e corale, dal ritmo insieme epico e lirico, di Quasimodo in Giorno dopo giorno. E a Quasimodo che
afferma «Sei ancora quello della pietra e
della fionda» in Uomo del mio tempo fa eco il «Noi infidi rupestri» di Bertoldo in Questo è il popolo, testo dove il verso «dell’incivile carlinga di popolo» richiama il quasimodiano «uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,/
con le ali maligne…», così come l’immagine «Suonano da sole le chitarre
ormai» evoca alla mente,
per analogia, quella delle cetre appese di Alle
fronde dei salici.
Eppure, per quanto nella silloge di Bertoldo il poeta
provi a configurarsi come deuteragonista e alla fine a annullarsi nel popolo, l’identificazione
non è di tipo psicologico, per quanto empatica, non porta alla completa immedesimazione,
in Poema del divino (il popolo è servo)
dichiara infatti: «Ho civilizzato le
foglie del lauro/ per poterti vedere senza ergere cattedrali». Come nel
teatro epico brechtiano l’immedesimazione è funzionale allo straniamento
dell’attore e, quindi, dello spettatore, che così può comprendere e partecipare
al dramma, analogamente in Il popolo che
sono (con i rinvii lessicali di ambito teatrale: pièce, platea, messinscena ecc.) il poeta, per etica
necessità, è popolo, ma è anche «inviso
dal popolo», come recita la quarta di copertina, e questo consente
all’interlocutore-lettore di giungere a fine lettura con una consapevolezza nuova.
La coscienza critica del destinatario attivo e compartecipe, sospesa tra scetticismo
e un’esile speranza («dateci l’amplesso
della speranza!» in Questa è l’Europa)
che parla di azione-rivolta (per questo nella silloge abbondano i verbi), di tenerezza,
amore e fratellanza, di una poesia nuova («La
poesia è nuova, è un’ostia brunita come ciocco» in Questa è l’Europa), di un’altra
luce, non già quella divina di dantesca ascendenza; ed ecco che il grido si
fa imperativo: «strappate l’ultima
maniera di essere uomini/ non è più tempo di fatuità» (Eppure eri morto). E l’imperativo è in primo luogo per il poeta,
per Bertoldo «La ricerca, nello scrittore, è tutto, quanto lo è l’azione
nell’uomo» (Principi di fenomenognomica,
cit.), ma l’opera d’arte ha valore e bellezza solo se eticamente autentica, «poiché
non c’è valore estetico senza progresso civile». Come il teatro di Brecht è epico così questa
poesia è epica, il sipario della finzione è strappato, il dramma è verità («Io che non mento di estetica/ ho delle
parole il gambo pressappoco» in La
firma), la natura, con la sua teoria di uccelli, piante, fiumi, mari, cieli
e luna, è la scena e il tempo è il qui e ora della storia in atto (con i
riferimenti alla situazione italiana, europea, alla Siria, all’Iraq e così via)
e se l’avvenire pare morto, c’è bisogno «di
costruire l’animalità di un passato», ma «solo il poeta risale sui versi le cateratte dei fiumi» (Questa è l’Europa).
Non si pensi, tuttavia, a una poesia astrattamente programmatica, la poesia di Il popolo che sono procede, secondo la poetica bertoldiana del «tonosimbolisomo» («nel correativo tonale è il tono a farsi latore dell’intuizione»), dalla sensazione, dalla percezione, dall’emozione, dall’intuizione; è una poesia paradigmatica, si dipana analogicamente per tropi e altre figure retoriche (metafore, metonimie, sinestesie, ossimori, antitesi ecc.) e sonoramente per allitterazioni, anafore, rime e rime interne, paranomasie, assonanze e consonanze: «Ho impaginato le mie metafore, ma erano lacrime/ lo so. Triste è il suono che sento, è la vendetta, / pulsa con un tono che è soave, lurido e soave» (Mio padre mi ha amato). E se l’andamento dialettico è confermato dall’insistenza sul contrasto colpa/perdono, la vis polemica si stempera nel canto, allora la poesia è insieme forza coatta («L’amore non sei tu ma è una voce coatta») e consolazione («invece tu sei la bocca che consola col canto» in Oltre l’amore). Nondimeno la letteratura è stata distrutta, così l’arte e la musica, il poeta è condannato, ucciso. Nella poesia Invettiva sotto una tomba etrusca, presente nella silloge Il sangue amaro (2014), Magrelli, con identica intenzione civile, secondo Romano Luperini, fa parlare il poeta non più sopra, ma sotto una tomba, da dentro, a dirne la «voce reclusa nel buio/ tra forme colorate, ma immobili per sempre/ come l’ultimo alito/ della nostra pronuncia». Allora piangere per i poeti morti è per Bertoldo La vera cultura, bisogna piangere e «…se un giorno piangerete per me/ spero che questo sia cultura». Bertoldo in modo circolare, però, riprendendo l’assunto che dà l’avvio alla silloge, il popolo che sono, conclude con l’epitaffio del poeta che vorrebbe eclissarsi rinunciando, di fronte al lettore da cui lo dividono i muri di carta del libro, alla sua vanità e forse pure all’identificazione (sapeva bene Pavese la difficoltà dell’intellettuale a essere popolo). Ora non è più il poeta-popolo a cantare, è il popolo stesso: «Non c’è ragione che si parli di me/ quando il popolo sul mio groppone/ eiacula poesie».




Simonetta Longo, "Non parole. Un gesto. Non scriverò più". L'addio come anticipazione, destino e profezia autoavverante ne Il mestiere di vivere e Verrà la morte e avrà i tuoi occhi di Cesare Pavese, in “Pentèlite”, nuova serie, anno 3, n.2, Siracusa, Morrone Editore, Siracusa, 2016. ISBN: 978-88-95936-61-1. Saggio critico.





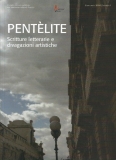


Prefazione di
Simonetta Longo alla silloge di Giuseppe Pettinato Come una conchiglia,
Morrone Editore, Siracusa, gennaio 2015.
Del dialogo sinestetico nell'atto definitivo della morte non restano che poche parole e il senso di una brusca separazione, che oppone Angelo e la sua pace al dolore di chi resta, al nostro dolore. Eppure, in questo diario scomposto, in questo «puzzle» (è parola dell'autore) smontato è proprio la circolarità a restituire il significato più profondo del libro, perché il 25 giugno 2014 è sì la fine ma anche il preludio di un dialogo che deve e può ricominciare nella poesia [...]
In Come una conchiglia, tuttavia, il dialogo sinestetico padre-madre-figlio si fa atto di conoscenza, da condividere con tutti coloro che leggeranno. La poesia e le arti si dimostrano così strumenti nodali per una possibile pedagogia della morte, e se il dolore assoluto per la deprivazione del figlio non consente una completa elaborazione del lutto, esprimerlo è un atto di rivelazione e liberazione.
(dalla quarta di copertina)



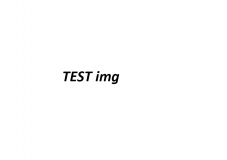
test test